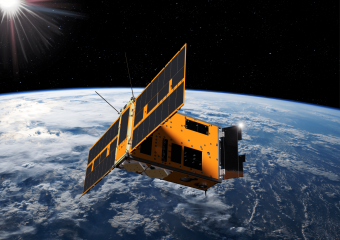Antonio Grego – Può descriverci, secondo il suo punto di vista, la situazione politica attuale interna della Russia? Come giudica l’operato dell’attuale presidente Medvedev?
Sergei Baburin – Dmitry Medvedev è un uomo molto intelligente, ma purtroppo per essere il capo dello Stato, non basta avere solamente la mente. E lui ha fatto tutti gli stessi errori che commise Gorbaciov a suo tempo, in effetti ne è il degno successore. E la cosa più triste è che lui essendo il capo di Stato, non prendeva in considerazione gli appelli dei nostri partner del G8 per ripensare, sulla scorta dell’esperienza della crisi finanziaria mondiale, il ruolo dello Stato e rafforzare le funzioni sociali dello Stato.
Infatti il presidente Medvedev ed il suo staff rimangono preda delle illusioni liberali. Delle illusioni che in economia non dovrebbe esserci la presenza dello Stato e che l’economia è capace di svilupparsi da sola. Nel mondo si è già dimostrato il contrario. E la Russia ha già cominciato a non stare strategicamente al passo nella comprensione delle sfide del 21° secolo. Questo non porterà a nulla di buono né per Medvedev né per la Russia.
La situazione politica interna in Russia è molto allarmante. Perché l’elite, o per meglio dire la nomenclatura politica, si è staccata dalla realtà. Si librano nello spazio, senza sapere cosa sta succedendo alla maggioranza della popolazione. È proprio questo il motivo che rende i processi rivoluzionari praticamente inevitabili. E il destino di Medvedev nel migliore dei casi sarebbe una ripetizione del destino di Gorbaciov. Anche se non escludo che ora, durante la compagnia per le elezioni presidenziali, Putin semplicemente lo metterà da parte e ritornerà. O proverà a ritornare al suo posto.
A.G. – La novità politica più importante di questi mesi, la creazione del “fronte popolare panrusso” (Общероссийский народный фронт) ad opera del primo ministro Vladimir Putin, sembra voler chiudere con gli anni della presidenza Medvedev, caratterizzati da un tentativo di normalizzazione e occidentalizzazione della Russia a cui ha corrisposto una politica estera poco incisiva e remissiva nei confronti delle pretese occidentali. Secondo lei questo nuovo partito può essere una occasione di ritorno ad una politica di forza e di prestigio per la Russia oppure si tratta soltanto di una mossa elettorale per riguadagnare i consensi ed i gruppi di interessi che in questo periodo si sono coalizzati intorno alla figura del “liberale” Medvedev?
S.B. – L’idea del Fronte Popolare io la predico da due anni. E un anno e mezzo fa la stavo discutendo con il presidente del Consiglio della Federazione di allora, Sergei Mironov, leader del partito “Russia giusta”, e con il leader dei comunisti Gennadij Zyuganov. Perché l’idea di Fronte Popolare presuppone l’unificazione delle masse popolari prive di potere politico, una larga alleanza per farle arrivare al potere e realizzare i loro ideali sociali.
Questa è la sostanza di qualsiasi fronte popolare. Perciò quando il Primo Ministro ha esortato a creare un Fronte popolare, negli ampi strati sociali questo ha destato stupore, anzi raggelamento. Stupore di chi non riesce a capire – ma che potere manca a quelli che creano il Fronte Popolare? Qual e’ il potere che vogliono prendere? Ce l’hanno già il potere, se si parla del partito “Russia Unita”. Se si parla del fatto che il partito “Russia Unita” ha deciso di attirare sostenitori… Già c’è un istituto di sostenitori di Russia Unita. Già dicevano fieramente che hanno milioni di sostenitori. Beh, diciamo che ora hanno deciso di fare tutto nel formato di una certa organizzazione, hanno chiamato questa organizzazione Fronte Popolare, ma non hanno risposto alla domanda – contro di chi è questo fronte?
Qualsiasi fronte popolare è contro il governo in carica. In Russia questo è stato, ad esempio, il Fronte di Salvezza Nazionale degli anni 92 – 93. E contro chi è rivolto questo fronte popolare panrusso di oggi? Nessuno ha risposto e non può rispondere a questa domanda. Bene, il raggelamento che questa iniziativa ha destato in quelli che si mobilitano c’è perché vengono invitate diverse persone e si dice: unitevi al Fronte Popolare se volete che vi vada tutto bene al lavoro. In questo modo si allineano in file regolari le varie società pubbliche, i cui capi sono già iscritti al partito Russia Unita.
Non molto tempo fa ho ricevuto una lettera dal presidente della Unione dei Rettori della città di Mosca, il Prof. Fedorov, in cui mi chiede come mi porrei nell’eventualità di un’adesione dell’Unione Russa dei Rettori al Fronte Popolare. Naturalmente, ho risposto in forma scritta che appoggio completamente l’adesione dell’Unione Russa dei Rettori al Fronte Popolare dopo l’uscita da quest’ultimo del partito di Russia Unita. Perché altrimenti è un assurdo. Partecipare all’assurdo io non lo voglio nemmeno per far compagnia. Di per sé, la creazione del Fronte Popolare non corrisponde in nessun modo ai processi di Medvedev, perché il Fronte Popolare assorbe tutti i devoti alle autorità. Il significato di un Fronte popolare così consiste solo in una prova di lealtà: “Hai confermato la tua lealtà iscrivendoti al Fronte Popolare oppure no?”. Non può nemmeno diventare una fonte di una qualche nuova dirigenza politica, come in questo caso cercano di dire “si”, Russia Unita è un sindacato dei burocrati del nostro Paese che stanno al potere.
Ma, il Fronte Popolare cambia la situazione in questo sindacato? Niente affatto. Se dal Fronte Popolare saranno reclutati candidati deputati alla Duma di Stato, queste stesse persone sarebbero state nominate candidati deputati anche senza il Fronte Popolare dalla stessa Russia Unita o dai suoi satelliti. Inoltre, un appello alla fondazione del Fronte popolare non poteva svolgere il ruolo di distrarre l’attenzione pubblica. Nessuno nella società ha guardato seriamente a questa organizzazione.
A.G. – Questo significa che Putin ha creato il Fronte Popolare per vincere alle elezioni?
S.B. – Per fare qualcosa di nuovo, perché sia Putin che Medvedev alla maggioranza degli elettori nel Paese sono venuti a noia. Russia Unita desta bruciore di stomaco, e questo si rileva nel fatto che la gente non va alle elezioni. Purtroppo, i massimi dirigenti non vogliono riflettere su questo processo, e non prestano attenzione al fatto che l’astensione per protesta alle elezioni sia già pericolosa. Il Fronte Popolare morirà silenziosamente, perché non si evolverà in nessun partito, non si evolverà semplicemente. Tranne per il fatto che Russia Unita cambia nome in Fronte Popolare.
A.G. – Il cosiddetto “reset” dei rapporti bilaterali tra USA e Russia, fortemente voluto da Obama, dopo un avvio promettente (firma del nuovo trattato START) si sta arenando a causa dell’ostinazione degli USA nella prosecuzione dell’allestimento dello “scudo antimissile” in Europa e nel supporto incondizionato di USA e NATO alle rivendicazioni della Georgia. Qual è la sua opinione in merito? Quale ritiene sarà la reazione russa al dispiegamento dello “scudo antimissile”, in particolare nelle zone dei “conflitti congelati” (Kosovo e Transnistria)?
S.B. – Credo che la questione del reset si bloccherà ora alle elezioni presidenziali del Presidente della Federazione Russa, perché gli americani hanno fatto capire diverse volte in maniera univoca che non vogliono vedere il ritorno alla carica di presidente di Vladimir Putin, che vedono per questa carica solamente Medvedev. Questo non accadrà. E quindi se gli statunitensi rivolgeranno l’attenzione solo su questo criterio, allora sarà un vicolo cieco totale e non ci sarà nessun “reset”. Se appoggeranno le pretese dei nostri confinanti, per esempio dei polacchi, con le loro speculazioni sull’argomento Katyn; della Georgia con le sue dichiarazioni che affermano che la Russia ha occupato l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia, allora sono sicuro che il periodo dell’approccio liberale verso di loro dal lato della politica estera russa stia finendo. L’Abkhazia e l’Ossezia del Sud sono riconosciuti come Stati indipendenti e non è possibile invertire il processo. Ma per quanto riguarda tutto il resto… Se gli Stati Uniti vivranno nel passato, allora sono condannati ad entrare nel periodo del fallimento strategico. Soprattutto tenendo conto del fatto che essi adesso hanno intenzione di far sprofondare l’Europa nel caos. Non riesco a spiegare in altro modo la destabilizzazione del Mediterraneo che hanno prodotto i nordamericani. Quindi gli avvenimenti in Tunisia, come pure in Egitto, e in Libia, e quello che avviene intorno alla Siria, non sono certo solo gli intrighi di Sarkozy. A Sarkozy si può attribuire, al massimo, solo la Libia. Lui ha fatto sparire le tracce della sua campagna elettorale, e cerca di farle sparire anche adesso. Ma per il resto è un colpo molto potente diretto alla destabilizzazione del Mediterraneo. Gli USA, tuttavia, non si sono resi conto che abbattendo i loro alleati in Tunisia e in Egitto, possono ottenere come contraccolpo il ritorno del mondo arabo alle posizioni anti-americane, cosa che già avviene oggi, il rafforzamento del fondamentalismo islamico, il potenziamento della presenza dell’Iran, soprattutto all’interno della Siria. Così richiamo la vostra attenzione al fatto che nemmeno gli statunitensi sono omogenei. La politica interna nazionale degli Stati Uniti è costituita da più centri di potere che l’immagine esterna non mostra. E che sia stato inflitto un colpo contro i sostenitori potenziali del Partito Repubblicano è palese. Obama non ha nulla da vantarsi. Dopo aver ricevuto il suo premio Nobel, non ha presentato le prove che sia un pacificatore. Non ha ritirato le truppe né dall’Afghanistan né dall’Iraq. Non ha concluso nessuna guerra. Ne ha scatenata una nuova. Pertanto adesso negli Stati Uniti la situazione intorno la guerra statunitense in Libia è molto difficile.
A.G. – Penso che gli USA si stiano comportando in maniera molto scaltra. Da un lato rassicurano la Russia che è tutto a posto, tuttavia, dall’altro lato, continuano il programma di scudo missilistico in Europa…
S.B. – Fate attenzione che in Polonia, quando si iniziò a rifiutare di partecipare alla realizzazione degli elementi dello scudo anti-missile sul territorio polacco, subito, in un misterioso incidente aereo rimase ucciso tutto il comando supremo dell’esercito, che si era schierato contro gli interessi degli USA. Si tratta di quei 28 generali che agivano contro il dispiegamento dello scudo missilistico statunitense. Poi, forse, per riequilibrare, hanno eliminato in un incidente aereo vicino a Smolensk anche i principali politici anti-russi, ma questo era già in modo chiaro colpa dei piloti e di quelli che gli hanno dato l’ordine di atterrare nella nebbia. Ma dopo questo fatto Donald Tusk (primo ministro polacco, n.d.t.), che aveva la possibilità di continuare la sua linea di atteggiamento critico al dispiegamento degli statunitensi e il ministro degli esteri, che fino a questo momento era considerato scettico, infine dopo consultazioni con gli USA hanno cambiato il loro punto di vista e hanno accettato il punto di vista di Washington rendendolo il proprio. E attualmente, appunto, ci sono tre questioni che secondo il mio punto di vista a lungo termine destabilizzeranno la situazione in Europa: il problema dello scudo antimissile statunitense, il il problema del Kosovo, che è una minaccia grave per la stabilità europea, e la Transnistria, come viene attualmente interpretata a Bruxelles.
Non molto tempo fa sono stato a Bruxelles, e mi sono sorpreso del fatto che in tutte le riunioni, presso l’Unione europea e il Parlamento europeo e presso la NATO la questione della Transnistria è diventata di primo piano. Proprio la regolarizzazione in Transnistria. E non in Moldavia, ma precisamente in Transnistria. Ho dovuto dire, avendo preso lì la parola, che i termini del discorso erano sbagliati. La Repubblica Moldava di Transnistria è uno Stato. Ci sono molti che non vogliono riconoscere la formazione di questo Stato, ma nel mondo è sempre così – c’è sempre qualcuno non vuole riconoscere qualcosa. E nello stesso tempo non è venuto fuori di propria iniziativa. È sorto quando nel 1990, l’amministrazione della Moldavia ripudiò la legge di istituzione della Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia all’interno dell’URSS, in base alla quale si erano uniti due territori. L’ex territorio occupato dalla Romania (è il territorio dell’attuale della Moldavia) e il territorio che non è mai stato sotto i romeni, e che faceva parte dell’URSS come Repubblica Autonoma di Moldavia, l’attuale Transnistria.
Loro stessi si sono, in questo modo, separati dalla Transnistria, poi si sono risvegliati e hanno deciso di riprendersela. E così iniziò il conflitto armato. Legalmente, dal punto di vista del diritto internazionale, la Transnistria esiste per legge. Questo non lo vogliono ammettere, solo perché il governo della Transnistria è orientato verso la Russia. Dopo tutto, se la leadership della Transnistria avesse dichiarato che è pronta ad aderire all’Unione Europea senza condizioni, ma come uno stato indipendente, l’avrebbero ammessa prima ancora della Repubblica di Moldavia. Ma ora per la Russia non c’è interesse né morale né politico a tradire la Transnistria. E per gli occidentali questa è una questione fondamentale. Qui sono sono dispiegate le truppe russe, qui si trova una popolazione che sostiene la Russia, è in gran parte sono cittadini della Federazione Russa. E impediscono alla Moldavia di essere assorbita dalla Romania. Questo nodo per l’Europa c’è e ci sarà. E se gli europei non si rendono conto che è necessario accettare lo status quo e riconoscere la Repubblica di Moldavia nei suoi confini attuali, e la Transnistria all’interno dei suoi confini, allora saremo in un vicolo cieco. E per la Russia, in futuro, spero si formi una sorta di unione, come la stessa unione doganale, che includerà la Russia, l’Ucraina, la Transnistria e, magari anche la Moldavia. Allora ecco questo spazio economico unico continuerà.
A.G. – Le difficoltà del governo di Silvio Berlusconi, sia in politica interna con il rafforzamento dell’opposizione e le sconfitte elettorali, sia in politica estera con una sostanziale rassegnazione verso decisioni prese oltreoceano che stona con la fase di protagonismo che aveva caratterizzato gli ultimi anni (asse Putin-Berlusconi-Erdogan) sono la spia di un processo di degenerazione e irreversibile decadenza sia per l’Italia che per l’Europa. In particolare la guerra in Libia, che l’Italia ha subito con un atteggiamento di totale impotenza, pare che abbia messo la pietra definitiva ad ogni tentativo di costruire una politica estera parzialmente autonoma dai poteri forti che tradizionalmente controllano l’Europa. La debolezza, per non dire “inaffidabilità”, di quest’ultima fase del governo Berlusconi ha minato i rapporti tra Italia e Russia? Come vede lo stato attuale dei rapporti tra i nostri due Paesi?
S.B. – Da un lato mi fa piacere che sulla base dell’asse Putin-Berlusconi, si rafforzino i contatti tra la Russia e l’Italia. Dall’altra parte tutti noi ci preoccupiamo che quando questo asse crollerà oppure cesserà lentamente di esistere, e ciò sicuramente avverrà, allora si rifletterà negativamente sui nostri rapporti, provocando un forte contraccolpo. Perché è un vero peccato che i rapporti personali tra Putin e Berlusconi siano un fattore dominante della nostra cooperazione. La collaborazione tra la Russia e l’Italia dovrebbe essere posta al di sopra e non dipendere né dalle amicizie dei politici e né da qualcun altro.
A.G. – Ma in realtà questo asse già non esiste più, perché la politica di Berlusconi è attualmente completamente cambiata. Dopo aver perso le ultime elezioni amministrative e soprattutto dopo l’inizio della guerra in Libia che ha visto il clamoroso tradimento dei patti con Gheddafi. Si nota che anche i rapporti tra Italia e Russia non sono più così intensi come prima. Perché lui probabilmente teme di nuovo una reazione degli USA a causa di questa politica indipendente tenuta in passato, quindi si e’ allineato al diktat d’oltreoceano… l’Italia certamente non voleva la guerra in Libia.
S.B. – Berlusconi ha cercato di prendere una posizione neutrale. Sono stato in Libia oltre 10 anni fa e ho visto come in quel periodo iniziava a crescere la cooperazione economica tra Italia e Libia. Ora io sono il presidente del comitato di solidarietà economica con i popoli della Libia e della Siria. E penso che gli europei, acconsentendo alla volontà degli americani e scatenando l’aggressione contro la Libia, naturalmente non solo hanno inflitto un colpo al diritto internazionale, travalicando la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma con le proprie mani hanno indebolito la stabilità dell’ordine europeo. La stabilità del sistema di sicurezza economica e politica.
Mi dispiace che la Russia effettivamente partecipi a tutto questo, così come l’Italia. La posizione della Russia in Libia è molto passiva e mal ponderata. Perché Gheddafi è un leader nazionale, sostenuto dalla maggioranza della popolazione. Le accuse che gli vengono avanzate oggi sono le accuse contro un capo che ha cercato di sedare disordini di massa. Dopotutto, non ci sono contro di lui altre accuse. Viene incolpato dell’uso della forza contro coloro che hanno usato la forza per prendere il potere. È una situazione assurda. Questo è un modo per incolpare qualsiasi capo di Stato. Inoltre, è un grave precedente, perché se in qualche posto un governante userà la forza contro una ribellione sollevatasi nello Stato, allora lo si potrebbe bombardare da fuori per impedirgli di toccare l’opposizione e farlo arrendere ai ribelli. Ecco dove sta la logica. Ma spero davvero che non solamente la Libia riuscirà a tenersi in piedi ma che anche Gheddafi ce la faccia. E che l’ordine di arresto del tribunale penale internazionale, assolutamente contrario al diritto internazionale e alla legge, sia annullato come un errore portando scuse ufficiali.
In primo luogo, loro non possono praticamente arrestarlo. In secondo luogo, il mandato d’arresto di Gheddafi, di suo figlio e del terzo dirigente libico, tutti questi ordini non sono legittimi perché secondo la statuto della Corte penale internazionale, la giurisdizione si applica solo a quegli Stati che hanno firmato e ratificato lo statuto. Ma la Libia non fa parte della Corte penale internazionale. Quindi sono convinto che oggi in Libia stanno perdendo molto seriamente sia l’Italia che la Russia. Gli statunitensi hanno coinvolto tutti mentre loro si ritirano. E poi si metteranno da parte e diranno: «pensateci voi!»
A.G. – Se Gheddafi non sarà ucciso, ciò significherebbe che l’America ha perso…
S.B. – Allo stesso modo, era chiaro che gli statunitensi non avrebbero permesso a Slobodan Milosevic di uscire vivo dal Tribunale dell’Aja che con la sua sola esistenza ricordava costantemente che, nel 1999, non è stata la Jugoslavia a violare il diritto internazionale. Ma è la coalizione della NATO che ha bombardato la Jugoslavia il vero criminale. Allo stesso modo, adesso non intendono rimettere in libertà dal Tribunale dell’Aia, l’ex vice primo ministro serbo e politico Vojislav Seselj, sebbene le accuse rivoltegli non sono effettivamente in grado di dimostrare nulla contro di lui. E sono d’accordo con Lei che la vittoria di Gheddafi è un disastro per gli Stati Uniti. Anche se cerchiamo di chiamare le cose col loro nome: la vittoria morale di Gheddafi si è in pratica già verificata. Non lo hanno ancora potuto uccidere. Inoltre, le tribù che abitano in Libia si sono mobilitate intorno a lui e lo sostengono. Infatti ora l’unica speranza di Washington e Bruxelles è proprio l’omicidio del leader libico e non semplicemente il suo rovesciamento.
Antonio Grego